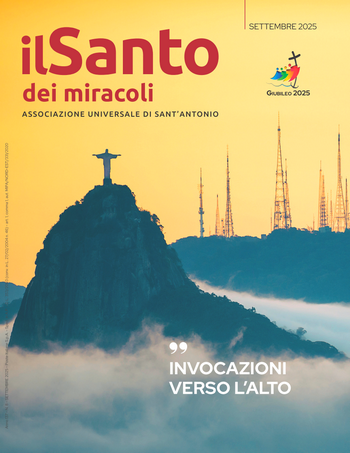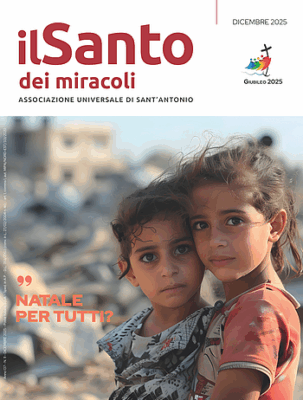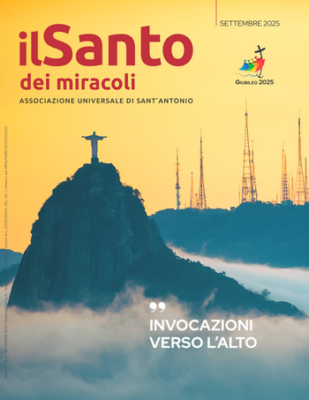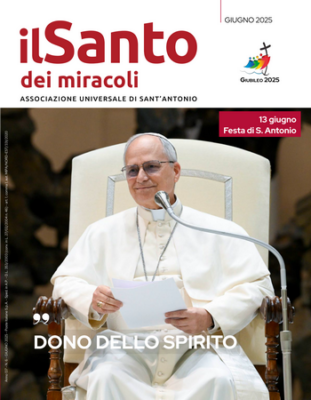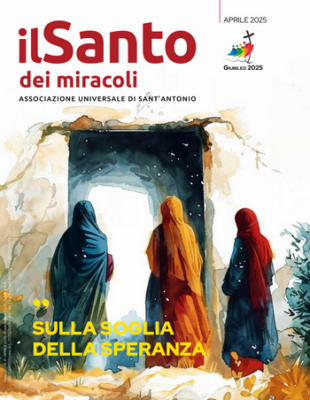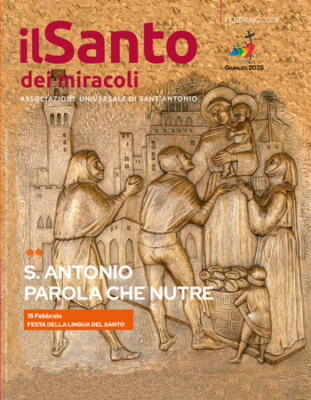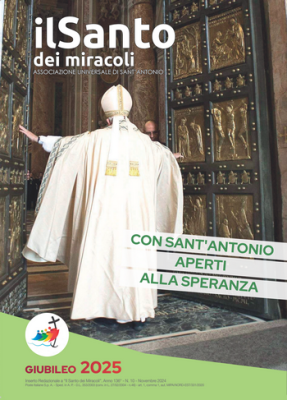Anno 137 - Settembre 2025Scopri di più
La mia preferita tra tutte le parole
Elide Siviero

Ho letto una intervista a Roberto Vecchioni, uno dei più importanti cantautori italiani, ma anche professore di lettere antiche, in cui gli chiedevano quale fosse la sua parola italiana preferita. Appena sentita la domanda, ho pensato immediatamente alla mia parola prediletta: amore. Mi è piaciuto quello che Vecchioni dice di questa parola, che per lui è la parola più bella della lingua italiana. Perché: «Racchiude in sé così tanti significati e sfumature: affetto, passione, dedizione, sacrificio». L’etimologia di questo termine italiano, secondo Vecchioni, viene da “kamami” che in sanscrito significa desiderare, perché il senso fondamentale dell’amore è il desiderio, cioè ti manca qualcosa di cui hai bisogno. «In persiano antico va via il “k” e viene l’aspirazione, “hamami”. Poi i Latini tolgono l’aspirazione e tengono il verbo “amami”, un bellissimo verbo perché tiene conto dei due suoni fondamentali dell’essere umano, la “a” e la “m”, che sono le stesse lettere che troviamo in amare e mamma, pronunciabili dal bambino subito».
Secondo lui, amare è vita perché è “a–mors” ovvero senza morte (la “a” posta dinanzi a un termine significa privazione), ma questo non è accreditato dai dizionari più autorevoli che invece sottolineano anche altre ipotesi etimologiche come una radice indoeuropea con un significato vasto e sorprendente: afferrare, prendere. Per il professor Michiel De Vaan, uno dei massimi esperti contemporanei di etimologia, il peculiare significato latino di amare si è sviluppato a partire dal gesto di afferrare, prendere la mano. Amare è tenere, al modo in cui significano “tenere” verbi come afferrare, attaccare, giurare. Insomma, è una etimologia affascinante quella per cui l’amore abbraccia, regge, promette come un desiderio e slancia come qualcosa che non muore e ci sostiene. L’amore è la potenza, quella che avvince e tiene nella stretta del palmo.
Credo che questa sia la parola italiana preferita. Ma penso che in tutte le lingue questa sia la parola favorita: love, amour, liebe, amor, lyubov. Perché senza amore non si vive. Mi colpisce che nel greco antico ci fossero più termini per indicare l’amore. I due principali erano filèo ed erào. Filèo indica una predilezione. È il termine tipico dell’amicizia. Erào indica soprattutto la passione. Per parlare dell’amore di Dio nel Nuovo Testamento si utilizza un verbo che era in disuso: agapào. È un termine che ci porta in un mondo diverso dagli altri due. Quello introdotto da Gesù Cristo. Questo verbo è formato da tre parti: aga che vuol dire molto, apo che indica il movimento da... a... qualcosa che si sposta da un luogo a un altro, e ao un suffisso che indica e provoca una situazione. È una composizione che ci fa arrivare a questo tipo di significato: moto da qualcuno a un altro, che crea una situazione. L’amore di Dio è quindi generativo, gratuito, personale.
Mi commuove il pensiero che Gesù abbia detto, nella sua preghiera sacerdotale, mentre affidava i suoi discepoli al Padre, «li hai amati come hai amato me» (Gv 17,23). Il vincolo dell’amore che sussiste tra il Padre e il Figlio è donato a noi: e questo amore non è un sentimento. È una persona: lo Spirito Santo, amore che permette la mutua donazione tra il Padre e il Figlio e travolge l’uomo in un vortice in cui tutti gli aspetti decantati dalle varie etimologie dell’amore sono espressi alla perfezione.
Nel momento della morte di Gesù è scritto che spirò, diede lo spirito, cioè dona lo Spirito Santo, dona la vita all’uomo regalandogli il soffio del suo segreto. E l’uomo in Cristo scopre cos’è l’amore: è dare la vita. Ogni giorno siamo chiamati a gustare il dono di questo Amore.


 English
English Français
Français